“Nell’improvvisazione di gruppo si viene a creare un’intimità che richiede, man a mano che si sviluppa, una specie di resa” Derek Bailey, Improvisation
Derek Bailey utilizza la parola resa per spiegare cosa succede all’interno di quella tribù temporanea, che é un gruppo di musicisti che suonano senza uno spartito davanti, quando un musicista interagisce con gli altri. Ogni musicista lascia andare una parte di sè, lascia uno spazio agli altri/al tutto e permette, quasi seguendo una convenzione sociale, di creare l’ordine superiore della magia dell’improvvisazione. Rileggendo queste parole ed ascoltando Lighthouse allo stesso tempo ho il problema di capire esattamente chi tra Wingfield, Reuter e Sirkis, abbia rinunciato a cosa, tanto sembra che tutti e tre, invece, abbiano aggiunto qualcosa a loro stessi.
Nel Febbraio del 2016 Leonardo Pavkovic, deus ex machina e produttore con l’etichetta MoonJune, riunisce il chitarrista Mark Wingfield, il touch guitarist Markus Reuter ed il batterista Asaf Sirkis in Catalogna, presso La Casa Murada, un castello dell’11esimo secolo riadibito a studio di registrazione. Non ci sono spartiti, ma solo idee di base scambiate via mail tra Wingfield e Reuter su come creare le improvvisazioni nell’arco di un paio di giorni. A questo punto della storia i due hanno mai suonati insieme, mentre Wingfield e Sirkis si sono già incontrati in Proof of Light, primo lavoro del chitarrista inglese per la MoonJune del 2015. Nella session che ne nasce verranno prodotti tre album, di cui Lighthouse é il secondo uscito in ordine di tempo dopo The Stone House uscito a Febbraio di quest’anno. A differenza dell’album gemello il materiale proviene dal 18 Febbraio, ovvero il giorno precedente alle registrazioni di The Stone House, e non ha la presenza del quarto elemento Yaron Stavi. Il bassista israeliano, partner di lunga data con Asaf Sirkis, arriva last minute quando già i tre hanno già prodotto il materiale che andrà a comporre Lighthouse, grazie ad un buco nella sua agenda. Di fatto arriva nello studio senza prove, ed il risultato é un lavoro totalmente improvvisato di altissima ispirazione pur con così pochi minuti di rodaggio alle spalle.
Lighthouse é il flashback a quello che era successo nella giornata precedente. Mi colpisce che il materiale non perda il minimo fascino rispetto al disco “cugino”. E’ un lavoro diverso, non solo ovviamente per la differenza di organico, ma per il contenuto narrativo. L’ispirazione nelle improvvisazioni é al massimo, ogni pezzo dimostra una densità narrativa altissima, crea un percorso, un’evoluzione. Ognuno sembra avere idee da buttare nella mischia che non finiscono mai dando vita a 7 tracce capaci di spaziare attraverso ambiti ritmi tirati prog, soundscapes, riff tonali ed atonali, strutturati e destrutturati: é davvero difficile immaginare non ci sia della scrittura alla base.
Mark Wingfield ha un background che definire sfaccettato forse é anche limitante. Ha prestato la chitarra in lavori che hanno incluso Peter Gabriel, Ian Ballamy, Dwiki Dharmawan, Jeremy Stacey, Thomas Stronen. Accanto a questo porta avanti l’attività come solista, dietro il bancone del mixer, come insegnante ed anche come compositore di musica contemporanea, nell’ambito della quale ha visto le sue opere suonate in alcune dei più importanti teatri europei. Ha alle spalle un numero consistente di dischi solisti che potrebbero essere catalogati forzatamente nella fusion solista, ma anche nel jazz trio, nel prog, nella musica etnica. Mark é un avido ascoltatore e collezionista di musica proveniente da Africa ed Asia.
La sua chitarra parte dall’influenza dei chitarristi fusion. Poi, come racconta nell’intervista ad Anil Prasad su Innerviews, ha cambiato strada: “Qualche anno fa ho deciso di non ascoltare più lavori di chitarristi. E’ stata una scelta dolorosa, ma sentivo che era necessario. La ragione era che ascoltavo grandi chitarristi come Pat Metheny o Allan Holdsworth e poi prendevo in mano la chitarra e mi ritrovavo a suonare come loro. Non era quello che volevo. Non ho ascoltato chitarristi per un po’ di tempo, ma altri strumenti”. Partendo da John Coltrane, Miles Davis, Keith Jarrett ed arrivando ai cantanti K.D. Lang, Nusrat Fateh Ali Kha, Betty Carter e la musica indiana, turca, africana. Questa filosofia é una chiave di lettura per capire le referenze nel suo playing: l’utilizzo ricco di sfumature della whammy bar per riprodurre un cantato naturale, gli accordi sovraimposti l’uno a l’altro a simulare l’estensione del pianoforte, oppure il robusto processamento del suono della chitarra a riprodurre le sfumature nel registro più alto di un sassofono o di una tromba.
Subito in Zinc abbiamo un assaggio della tecnologia alle spalle di Reuter e Wingfield: quest’ultimo apre con un riff modale scurissimo, raddoppiato dal pitch shifter. Entrano Reuter, con un muro di accordi black, e Sirkis con un mid-tempo che piacerebbe a Pat Mastelotto. Wingfield costruisce un solo, senza alcuna cadenza, senza vere e proprie frasi, spesso rimanendo su una nota, tirandola all’estremo, processandola, sostenendola per lunghissimo tempo grazie all’uso di un sustainer aggiunto alla sua chitarra. Il suono della chitarra sembra la tromba di Nils Petter Molvaer. Il tutto mentre sotto, sfruttando i loop del Roland VG 88 attraverso un Mac, pianta un accordo pieno di diminuite che funge da soundscape immobile per tutto il brano.
L’improvvisazione totale di gruppo ha una storia anche al di fuori del jazz più tradizionale, differentemente da quanto spesso si pensa. Ascoltando Lighthouse i riferimenti che mi vengono in mente sono tanti progetti anni ’90, su tutti i due album di Bozzio Levin e Stevens. Ma qui hanno un approccio diverso all’improvvisazione. Lì c’era la necessità di sviluppare un riff dopo l’altro, costruire una narrativa tematica, creare una sottostruttura da sonata. Qui é prima di tutto l’improvvisazione che regna sovrana, ogni sfumatura porta ad una reazione degli altri componenti, attraverso un armamentario di sfumature -e di controllo su queste sfumature, pensando all’elettronica impiegata- impensabile in tanti gruppi jazz. L’esempio allora più vicino é quello dei vertici dei ProjeKcts e di un approccio all’improvvisazione totale elettrica.
Wingfield racconta come é nato il lavoro: “Prima delle sessioni io e Markus abbiamo discusso un approccio alla musica, decidendo che volevamo creare un lavoro largamente improvvisato, sfruttando regole o strutture algoritmiche come forme di composizione. Alcune erano regole piuttosto semplici. Altre indicavano specifiche note, se non addirittura l’ordine o la struttura ritmica in cui volevamo suonare. Altre erano rappresentazioni grafiche che indicavano come la musica si sarebbe formata ed evoluta. Tutte le progressioni, le melodie, le figure musicali e le parti ritmiche sarebbero state improvvisate, nessuna scritta in anticipo. Alcune tracce sono iniziate da una regola oppure da uno schizzo -per esempio, un pezzo che inizia con molto spazio, e poi diventa veramente denso prima di ritornare ad un approccio più spaziale- ma dopo una trentina di secondi che avevamo iniziato a suonare, abbiamo capito che era un problema di ascoltarci a vicenda e reagire al momento. La nostra discussione a proposito di regole e strutture ha giocato un ruolo importante nel preparare i presupposti, anche se poi alla fine non li abbiamo utilizzati poi tanto: non penso che senza quelle discussioni la musica avrebbe preso la forma che ha poi effettivamente avuto”.
Strutture che si vedono nella seconda traccia, Derecho. Ancora una volta Reuter é alla parte ritmica: stavolta con un riff indiavolato in 7/8. Sirkis non ha problemi a seguirlo, con i piatti in 7, mentre il rullante prosegue a volte in 7, in 9 -altre volte sembrerebbe in 15, ma é davvero difficile leggere le poliritmie del batterista israeliano. Un muro sul quale Wingfield costruisce un solo che parte con una meravigliosa frase di quattro note, capace di costruire subito un mood indecifrabile. Poi continua con whammy bar -ricorda l’uso che ne fa Nguyen Le- processamenti e riverberi a far ululare la chitarra nel registro più alto. A questo punto entra anche Reuter con una breve coda atonale. Il finale é tutto per il solo di Sirkis sulle chitarre slabbrate e su un acuto irreale, sembra quasi un sassofono, di Wingfield.
Markus Reuter, per motivi strutturali legati alla sua touch guitar, é più dedito alle parti di accompagnamento in Lighthouse di quanto non lo fosse nella session con Yaron Stavi in aggiunta di The Stone House. Questo strumento é stato sviluppato da Reuter stesso, partendo dall’idea del Chapman stick, di uno strumento suonato con il tapping e che avesse un’estensione di registro tra chitarra e basso. Ma questa é solo una delle attività che Reuter ha perseguito. Dopo aver frequentato i Guitar Craft tenuti da Robert Fripp, ha continuato a rimanere nell’universo dei King Crimson attraverso le collaborazioni con Trey Gunn, Pat Mastelotto (nei Tuner, poi TU), con Levin e Mastelotto negli Stick Men e con i Crimson ProjeKCt, il gruppo con Adrian Belew che ha riproposto il repertorio prima della attuale reunion dei Crimson.
Accanto, però, alle influenze derivate dallo stile di Gunn e di Levin sullo stick e Warr guitars, il musicista tedesco ha aggiunto un bagaglio differente, flessibile a seconda delle varie collaborazioni, come ad esempio i soundscapes del duo Centrozoon, oppure le improvvisazioni totali con Tim Motzer. Accanto all’improvvisazione, allo sviluppo di strumenti, Reuter ha sviluppato un corso di Psicologia della Creatività nel 2007, ha creato una sua etichetta ed ha praticato anche la composizione di opere orchestrali -come in Todmorden-513.
Mettere insieme due mondi contrapposti come composizione richiede una visione forte dietro la musica. “Gli esseri umani sono macchine per riconoscere patterns”, é un principio guida che ripete frequentemente. Fa riflettere rileggerlo e poi risentire le stimolazioni reciproche -la lettura di pattern improvvisativi?- con gli altri due musicisti in Lighthouse.
Ghost Light é il mio personale prezzo del biglietto, il pezzo che riesce a muovermi di più dell’album. Difficile resistere alle citazioni del Terje Rypdal di Odyssey -mi riviene in mente Adagio. Markus Reuter piazza una progressione al soundscape che davvero sarebbe difficile non sentire influenzata dal chitarrista norvegese. E Wingfield si muove cantando con spaziosità su questo tappeto. Sentite ad 1.44 una scaletta ascendente con il suono molto pulito, difficile non ricordare tanti soli appunto di Rypdal. Man a mano che la progressione sembra virare senza un centro tonale su territori più inaspettati, Wingfield continua con il suo solo. E Sirkis gioca, soprattutto sui piatti, con un suono scintillante -ancora riferimenti ad un sound ECM- e su brevi ed occasionali rullate. Il solo alla fine si sfalda in note tirate ed allungate fino a lasciare Reuter accennare a brevi accordi. Un ticchettio appena in sottofondo prima che Sirkis ritorni con qualche breve rullata. La touch guitar riprende una progressione più organica, struggente, su cui va in sintonia Wingfield alla melodia e Sirkis con i piatti. Nel finale il soundscape é diventato aggressivissimo, una fiammata che si stempera lentamente sotto accenni lirici di Wingfield.
Transverse Wave é costruita su un moto contrario e parallelo che ricorda molto da vicino Light ConstruKction dei ProjeKct Three e che fa capire ancora una volta l’alto livello di intesa dei tre. Come anche la chiusura di Surge, aperta da un riff prog atonale di Wingfield su un tempo abbastanza sostenuto, che poi sfocia in un finale caotico, veloce e densissimo sia a livello di suoni che di tempi.
In definitiva, Lighthouse é un disco che suona in maniera stupenda -si sente il lavoro di postproduzione di Mark Wingfield- prodotto da tre musicisti capaci di piegarsi alla disciplina dell’improvvisazione in maniera incredibile.
Wingfield, Reuter, Sirkis
Lighthouse
Mark Wingfield – chitarra
Markus Reuter – Touch Guitar
Asaf Sirkis – batteria
- Zinc
- Derecho
- Ghost Light
- Magnetic
- A Hand in the Dark
- Transverse Wave
- Surge
MoonJun MJR088
Mark Wingfield:
http://www.innerviews.org/inner/wingfield.html
http://www.innerviews.org/inner/wingfield2.html
Markus Reuter:
http://www.innerviews.org/inner/reuter.html
http://www.innerviews.org/inner/reuter2.html
Asaf Sirkis:

![Wingfield Reuter Sirkis – Lighthouse [MoonJune 2017]](https://markellosnardoi.files.wordpress.com/2017/10/mjr088-m.jpg?w=1200)
![David Virelles – Gnosis [ECM 2017]](https://markellosnardoi.files.wordpress.com/2017/10/david-virelles-gnosis.jpg?w=1200)
![Borderlands Trio – Asteroidea [Intakt 2017]](https://markellosnardoi.files.wordpress.com/2017/10/cover2.jpg?w=1200)
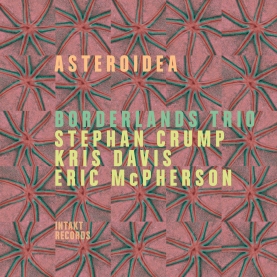 Asteroidea é un grande studio su improvvisazione e ritmo, dato in pasto a tre musicisti che si cibano di qualunque cosa. Il Borderlands Trio è attivo da un anno, ma é difficile non condividere l’esaltazione nel booklet per la sinergia già affinatissima dei tre. Il piano preparato di Kris Davis, il contrabbasso di Stephen Crump e la batteria di Eric McPherson dialogano spesso senza pace alternando poliritmie, sezioni tiratissime che passano con grande fluidità tra soluzioni ironiche o introspettive, ostinati di derivazione minimalista, improvvisazione free ed avanguardia del secondo novecento.
Asteroidea é un grande studio su improvvisazione e ritmo, dato in pasto a tre musicisti che si cibano di qualunque cosa. Il Borderlands Trio è attivo da un anno, ma é difficile non condividere l’esaltazione nel booklet per la sinergia già affinatissima dei tre. Il piano preparato di Kris Davis, il contrabbasso di Stephen Crump e la batteria di Eric McPherson dialogano spesso senza pace alternando poliritmie, sezioni tiratissime che passano con grande fluidità tra soluzioni ironiche o introspettive, ostinati di derivazione minimalista, improvvisazione free ed avanguardia del secondo novecento.![Bjorn Meyer – Provenance [ECM 2017]](https://markellosnardoi.files.wordpress.com/2017/10/bjiorn-meyer-provenance.jpg?w=1200)
